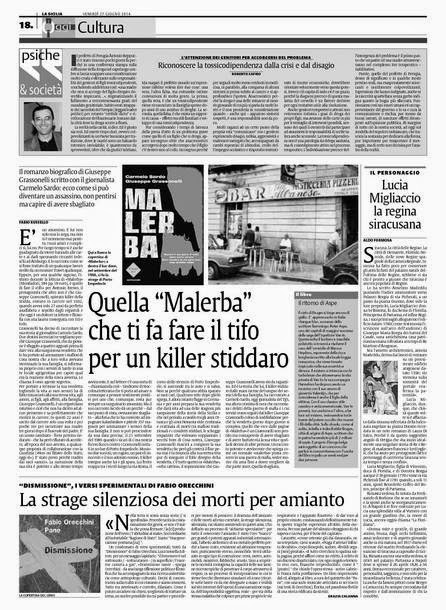Benedetti: la poesia
è venire ai ferri corti
con l’esistenza
di GRAZIA
CALANNA su LA SICILA del 18.09.2014
“Anni che non dovrebbero più, ore che non
dovrebbero / prendermi i giorni, le settimane, i mesi. Il tempo / portato
addosso, il sosia a cui chiedo di aiutarmi. // Con la sedia di mio padre gioca
la bambina che non conosco. / Adesso è sua. Gioca con quelli che diventeranno i
suoi ricordi.”, versi di Mario Benedetti schiudono “Tersa morte” (Mondadori),
itinerario esistenziale di sorprendente nitidezza, come deve esserlo la
testimonianza, col quale ha vinto la sezione poesia del XLV Premio Letterario
Brancati Zafferana.
-Quali i ricordi legati alle prime
poesie?
«Vittorio Sereni e la sua raccolta ‘Frontiera’».
-Cesare
Viviani definisce la lettura della poesia un atto creativo, un’esperienza unica
della parola creante, un atto irripetibile. Qual è la sua opinione in
proposito?
«Certamente è un
atto irripetibile, anche per la qualità della dizione. A volte è un fatto
meccanico senza trasporto e in questo caso forse il risultato è migliore».
-Riporterebbe
un piccolo stralcio di testo nel quale è solito “rifugiarsi”?
«Ora non ho rifugio alcuno, per circostanze e
incapacità tutte mie. Forse ancora ‘Genti’ di Andrea Zanzotto, per esempio rimanere
su questi versi: “E talvolta mi abbacina un prato / dimenticato dietro una casa
antica, / solitario, che finge indifferenza o / lieve o smunta distrazione //
ma forse soffre, forse è soltanto / un paradiso”».
-Per
Baudelaire “la poesia è quel che c’è di più reale: è completamente vera
soltanto in un altro mondo”, per
Benedetti?
«Per me è testimonianza (da parlante e da
scrivente) di un'esperienza umana che consiste nel perseguire il celebre motto
od obiettivo primonovecentesco: "venire ai ferri corti con la vita".
Non credere troppo al sapere stilistico-formale (che è laboratorio propedeutico)
ma avere cose da dire. Mi chiedo perché un poeta come Ungaretti abbia
intitolato la sua Opera: ‘Vita di un uomo’. Perché le risposte di Sereni
o di Montale in molte interviste rispetto alla nascita, ed anche alla stesura
del testo, rimangono un discorso poco articolato fatto di monosillabi o
indicano la presenza di un'occasione, uno stato particolare indefinibile
e banalmente feriale? Esiste una condizione anteriore alla storia letteraria
dei testi in sé stessi e per sé stessi. Poi ho un'altra sensazione e una
domanda: ma essere mortali, ma veramente mortali, cosa significa? Quantomeno
per me ora è attraversare uno stato di paralisi in cui continuo ad osservare il
finire come un semplice e terribile dato di fatto, dicibile ma evidenziando le
finzioni e gli infingimenti di cui ci nutriamo (perché non pensare benché sia
cosa trita a Leopardi?). Ma non ho presunzioni, davvero. Certamente, la
conseguenza è che sento svalutati gli scenari della vita, mia e di tutti. Ma
chiederei venia per questo mio stato d’animo e per questo pensiero».
-In un tempo
in cui “non importa quello che si vede, non importa / quello che si dice o
quello che si scrive”, qual è il ruolo del poeta?
«Ho punti di vista molto personali a questo proposito
che non sono in grado qui di esporre ma vorrei discuterne e poterli chiarire
meglio anche a me stesso. Mi sembra che il tempo di cui lei parla non sia messo
a fuoco da me per quanto riguarda l’ambito storico-sociale
ma sia circoscritto a me solo e alla mia esperienza: ciò che fuoriesce, e che
pure mi interessa, non è sotto il mio controllo».
-La invito a
scegliere una sua poesia per salutare i nostri lettori.
«Mi sento legato a questa, per me è come un’eco del
‘Funeral Blues’ di W. H. Auden: ‘Mandami
le ossa, mandami il cranio senza gli occhi, / la mascella aperta, spalancata,
fissa nei denti, / e i calzini sotto la tuta, eri rigido, eri rigido, eri una
cosa / come un’altra, senza la forma che hanno i tavoli, / morso dallo stento
del vivere, una cosa inservibile, / indecisa, un terriccio che non si nota, un
pezzo di asfalto / di una strada
anonima, eri tu, quella cosa, eri tu, / quella cosa, eri uno che è
morto. Così fragile il tuo sorriso, / lo sguardo blu e gli zigomi, il metro e settantacinque /
portato come un uomo che piace, che vive
per sempre, / per sempre dentro una vita che per potere essere / vissuta deve
sembrare una vita per sempre, mentre eri / della carne, quello che io sono uno
per sempre ancora.’».
GRAZIA CALANNA